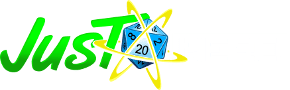Le intelligenze artificiali, ormai lo abbiamo capito, non sono esattamente l’ideale per prendersi cura dell’umanità. O almeno è quello che decenni di fantascienza ci hanno insegnato, partendo da Alien sino al deludente Tau, film originale Netflix. Ed è nuovamente Big N a tentare di raccontare il rapporto tra intelligenze artificiali e umanità, con un film dal titolo profetico: I am Mother.
I am Mother porta su Netflix un insolito nucleo famigliare
Film molto atteso, che mette nuovamente sotto esame le produzioni originali Netflix. Ancora una volta, il colosso dello streaming attinge alla famigerata Black List di Hollywood, il registro de facto dei progetti meritevoli ma che non vedono realizzazione per mancanza di fiducia da parte dei produttori. Una schiera di titoli che negli anni ha ospitato Argo, The Millionaire ed alcune produzioni di Netflix, come Mute.
I am Mother ha lasciato il limbo del Black Book, dopo che la sua sceneggiatura era stata messa in stand by nel 2016. L’idea di Michael Lloyd Green, ispirata dal romanzo ‘The search for WondLa’ era però affascinante, al punto che finalmente lo scorso gennaio questo film prende vita, mostrandosi in anteprima al Sundace Film Festival.
L’idea alla base di I am Mother non è particolarmente originale, ma riesce a mostrare una certa personalità grazie ad un rivisitazione degli elementi narrativi interessante.
Dopo una misteriosa tragedia che ha quasi condotto l’umanità all’estinzione, Mother è un androide incaricato di custodire un bunker hi tech, in cui sono conservati gli ultimi embrioni umani, la sola speranza di ripopolare la Terra. Per dare vita a questo progetto, Mother ha il compito di creare una nuova generazione di umani, che sappiano ricostruire una società oramai inesistente.
Per aggirare il rischio della ripetitività, Michael Lloyd Green ha imbastito un convincente contrasto emotivo tra la concezione naturale del concepimento e crescita dell’individuo, tipica dello spettatore, e il modo asettico e puramente funzionale con cui viene gestito il compito di Mother.
Nelle prime scene assistiamo alla nascita di una bambina, dallo scongelamento dell’embrione da utilizzare sino alla sua prima infanzia. Il rapporto tra la piccola e l’androide è costruito con attenzione e abilmente giocato sull’antitesi del freddo robot con il ruolo genitoriale classico, in cui amore e regole convivono. Si tratta di un intreccio di suggestioni non facile, a cui il regista Grant Sputore contribuisce offrendo riprese che valorizzano i piccoli eventi della vita interna alla base.
L’ambiente algido e claustrofobico, infatti, veicola alla perfezione l’idea di fredda logica dietro la ragione d’esistere dei due personaggi, ma viene spezzato con fugaci lampi di emozione in cui l’innata sensibilità della piccola protagonista cerca di ritrovare quell’essenziale calore umano che le è indispensabile.
Lloyd Green imbastisce una storia in cui l’emotività dello spettatore viene abilmente indirizzata, lasciando per un attimo da parte le spiegazioni sul perché ci troviamo ad affrontare la necessità di ripopolare la Terra, preferendo mostrare il modo in cui la giovane viene cresciuta. Mother non ha la complessità emotiva per comprendere appieno le necessità e la mente agile di un’adolescente e quando la sua protetta arriva a farsi le prime domande, deve fronteggiare una situazione imprevista.
Da notare come non ci siano nomi propri, ma solo termini generici. Mother non è il nome del robot, quanto la sua funzione, così come la protagonista è semplicemente chiamata Figlia. L’uso di un nome proprio avrebbe comportato anche, implicitamente, allo sviluppo di una personalità individuale, aspetto che non è previsto nei meandri metallici che sostengono l’androide.
L’illusione che ci si possa trovare di fronte ad un androide empatico è stata ben sottesa, ma la realtà è stata precisata dalla stessa macchina
“Sono mossa da parametri differenti, ma sono una buona madre”
Tutto sta a comprendere quali siano questi parametri, una ricerca di comprensione che spingerebbe quasi a tirare in ballo le Tre Leggi della Robotica. In realtà, è molto più semplice: Mother ha uno scopo, per il quale farebbe tutto.
Proteggere Figlia è un’esigenza non affettiva, ma pragmatica. La visione robotica del ruolo genitoriale è presentata allo sguardo dello spettatore come portatrice di una lieve emotività, complice una voce femminile apparentemente calda nella sua modulazione, ed alcuni istanti di ingannevole calore, come spostare un letto o il semplice attaccare un adesivo.
Il punto di rottura è l’arrivo di una donna dall’esterno, interpretata da Hillary Swank. Anche lei senza nome, altra figura che viene identificata dalle proprie azioni, capaci di mettere in discussione il mondo di Figlia e Madre, andando a minare le sicurezze con cui la giovane (interpretata ora da una convincente Clara Rugaard) è cresciuta.
L’idea di due donne forti, di concepire l’androide come una figura femminile è una scelta interessante. Hillary Swank sembra raccogliere l’eredità delle grandi eroine della sci-fi anni ’80 e ’90, come Ellen Ripley o Sarah Connor, mostrando una donna forte e capace di opporsi alla fredda logica della genitrice robotica. Non da meno Claudia Rugaard, capace di evidenziare il progressivo mutare della coscienza di Figlia.
I am Mother diventa, a questo punto, appassionante. La ricerca della verità da parte di Figlia, la manipolazione di Mother e le rivelazioni della sconosciuta sono elementi che creano un vortice emotivo gestito con sufficiente attenzione, sfruttando l’elemento claustrofobico del rifugio come una prigione fisica a cui Figlia non riesce a rinunciare completamente, affettivamente legata a quella fredda genitrice.
Il valore di I am Mother è, però, nei colpi di scena finali, che mostrano una complessità di trama e una costruzione ricercata davvero encomiabili. Sino all’ultimo il ruolo di Mother è meticolosamente adeguato all’esperienza finale dello spettatore, si adegua e sviluppa in modo da non dare una connotazione definitiva, sino a quando viene inserito l’ultimo dettaglio, e l’intero film assume una nuova sostanza.
Dopo avere trattato in altri frangenti il rapporto uomo-tecno logia, da Black Mirror al recente Love, Death & Robots, Netflix ha trovato il giusto punto di equilibrio, grazie ad una storia che supplisce ad una carenza di spunti originali una buona trattazione del tema, mai lenta ma con una corretta scansione dei tempi narrativi.
Dopo The Perfection questa seconda conferma di buon cinema da parte di Netflix potrebbe quasi far sperare che il colosso streaming abbia finalmente imboccato la strada giusta. Vediamo cosa ci presenterà il futuro, se ulteriori conferme o sonore delusioni.